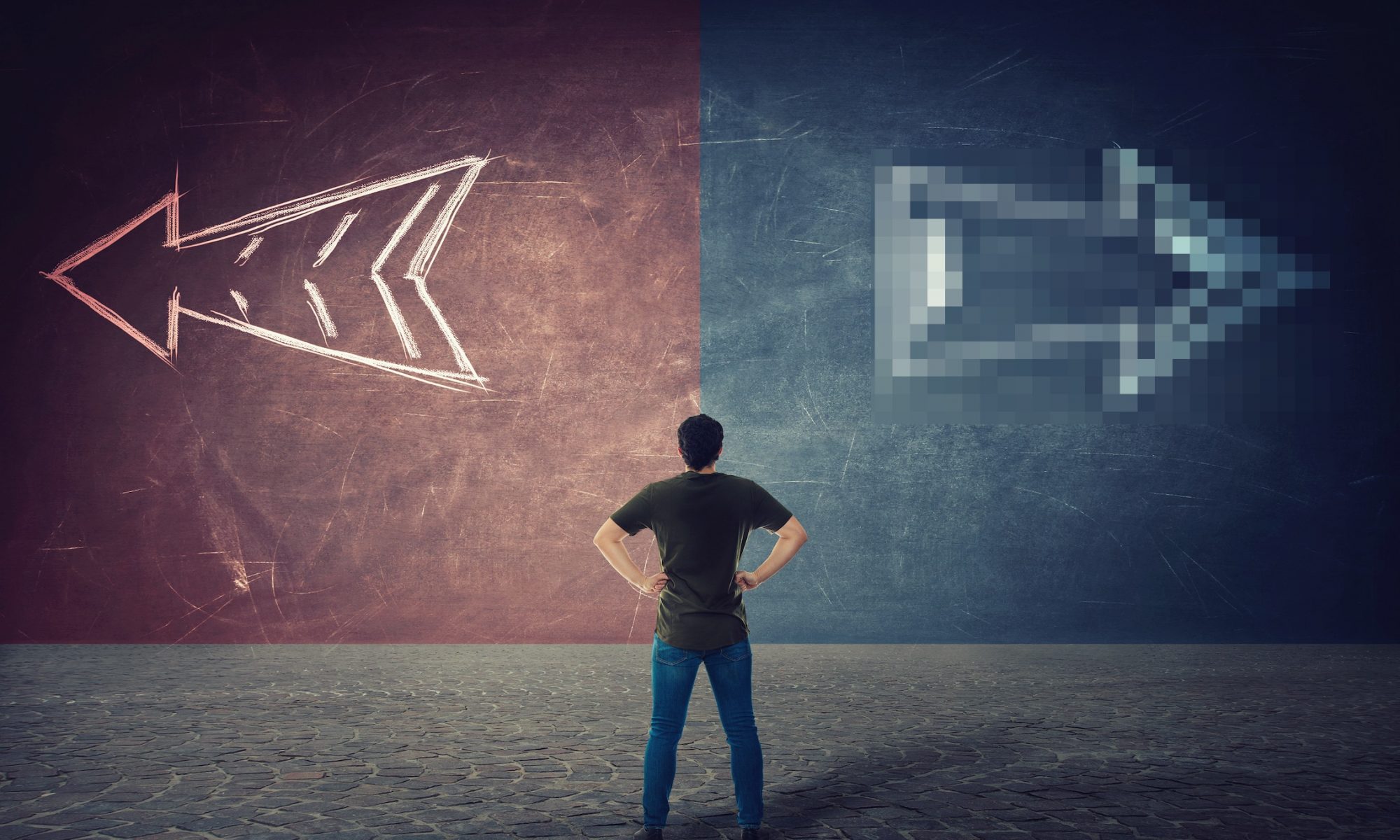Editoriale per Domani
Festa della zucca di Pecorara sull’appennino di Piacenza, che già pare il carteggio della scenografia di Cesare Zavattini, e Giulio Tremonti sibilante invita gli astanti, militanti della Lega Nord a guida bossiana, ad “occupare l’Emilia”, mentre quelli invocavano la secessione unendosi alla Lombardia. L’avanzamento delle camicie verdi verso sud ha nel mirino la terra rossa emiliana e la crescita elettorale è in quegli anni – siamo nel 2009 – prologo del tentativo, poi fallito, di un partito nazionale a guida Matteo Salvini da Locri. Nessuno a sinistra prende sul serio l’intento leghista, e il PD si crogiola su fasti ormai decadenti. Qualcuno che scrive, legge e analizza le sorti dell’Emilia fu rossa esiste, ma l’auto-considerazione dei dirigenti è elevata, salvo trasformarsi in auto-commiserazione appena il vento cambia come se non ci fossero stati cattivi, evidenti, presagi ad annunciare tempesta. L’incitamento/motto del ministro delle Finanze diventò anche il titolo omonimo per un ben fatto documentario (Lombardi-Tomassone-Aurighi), ma le vittorie, pur rocambolesche, tacitano quasi sempre tutto e tutti. Tanto che la sorpresa aleggiava ancora allorché la Lega (Nord) del sen. Salvini nel 2020 rischiò il colpaccio vittoria, se non fosse stato per la super mobilitazione e per il contributo dell’area metropolitana bolognese, e se non avesse candidato una figura politicamente evanescente. Ma nel PD ancora le ragioni di quella vittoria non sono state ben investigate, e pertanto non capite adeguatamente.
Il Partito democratico dovrebbe produrre una azione politica analoga e di segno contrario, una pianificazione di “conquista” elettorale. Perché? Per varie, concomitanti e convergenti ragioni. È impossibile, impraticabile, ambire ad essere partito di governo nazionale senza la guida almeno di Lombardia e/o Veneto, come minimo di una delle regioni più prosperose, ricche e popolose. Il PD non può limitarsi alla gestione delle grandi città, delle aree metropolitane; non sarebbe credibile, oltre che non competitivo. In Italia il 70% dei comuni ha meno di 5.000 abitanti, che rappresentano il 17% della popolazione nazionale; di tutti questi il 45% si trova dislocata tra Piemonte, Lombardia e Veneto (fonte ISTAT). Inconcepibile non avere una prospettiva per governare il Nord, che implica l’accento su una netta distorsione geografica, con l’enfasi su talune aree e la quasi assenza in altre, frutto di insostenibili differenze geografiche. Il PD non è il partito della ZTL, una definizione facile per i talk show domenicali, è piuttosto il partito dei dipendenti pubblici. Il dato su chi siano gli elettori democratici genera la condensazione e la concentrazione spaziale, e non il contrario. L’aspetto geografico è una conseguenza e perciò distorcente se assume caratteri esplicativi. Se guardiamo alle caratteristiche socio-demografiche e professionali, emerge un quadro inquietante per il Nazareno. Un solo dato circa le professioni: gli operari che hanno votato PD erano il 23% nel 2013 e solo il 10% nel 2018 (fonte ITANES).
Le ragioni di una riscossa che parta da Nord, come detto, sono molteplici e poggiano su basi agilmente spendibili sul piano politico, elettorale e persino comunicativo. L’asse lombardo-veneto non rappresenta affatto un “modello” di buongoverno, come da sedicenti esaltazioni e da troppo remissive qualunquiste asserzioni. La Giunta e l’amministrazione del Veneto e della Lombardia rappresentano in realtà casi esemplari di malgoverno, per molti aspetti. Dalla sanità, martorizzata e consegnata ai privati, alla gestione del territorio e dell’ambiente. Dai diritti sociali a quelli civili, posti in secondo piano rispetto al perseguimento esclusivo della difesa degli interessi imprenditoriali, o meglio solo di una parte di essi. Il Presidente Luca Zaia è un politico di professione, eppure si presenta come parvenu, ed è meno valido come amministratore di quel che si narra. Perché manca un racconto alternativo credibile. È un politico per nulla “moderato”, ma ha i tratti ideologici tipici dell’estrema destra (basterebbe ricordare i molti momenti di puro razzismo), come il partito cui appartiene, sebbene ogni tanto provi tatticamente a sganciarsene. Parimenti, nel caso lombardo la mala gestione della pandemia è evidente, come la disarticolazione degli istituti di welfare e una allegra e lasca amministrazione del bene pubblico e delle nomine politiche. Il Nord rimane perciò centrale. Nel post Liberazione si parlò di “Vento del Nord”, a indicare l’aria di libertà che spirava in seguito alla lotta di Resistenza e al movimento civico-politico che ne scaturì investendo l’intero Paese. Oggi nelle regioni settentrionali vivono e lavorano la maggior parte degli operai e dei lavoratori dipendenti, ossia l’elettorato “tipico” dei partiti progressisti, almeno nella storia e nell’afflato. E, dunque, in prospettiva. In termini di rappresentanza Lombardia e Veneto generano una quantità di seggi pari a quasi un sesto del totale, derivante dalla popolosità, mentre il Sud si svuota con la continua migrazione unilaterale. È tempo di impiantare una squadra speciale, a tempo pieno, con azione e impegno effettivo permanente. Amministratori locali, dirigenti ed eletti del PD, esponenti di associazioni, intellettuali, lavoratori e imprenditori. Una vasta operazione di ascolto, di apprendimento, di raccolta dati, di incontri. Attivare militanti, giovani, donne, precari, in territori dove la disuguaglianza è cresciuta enormemente ed esiste una sete atavica di sinistra e di diritti sociali. Una domanda inevasa di partecipazione e di rilancio dei valori progressisti. Per “occupare il Nord”, partendo dai molti dati ed analisi presenti, ma tentando di riconnettersi “sentimentalmente” con quel mondo. Una riunione mensile della Direzione nazionale svolta nelle province lombardo-venete sarebbe l’ideale, da ripetere con incontri periodici itineranti in giro per il Paese. Per dare un segnale, ma soprattutto per raccogliere idee, critiche e informazioni. Andare nella tana del lupo, e stanarlo. È un lavoro di lunga lena, ma da qualche parte e prima o poi bisognerà principiare. Un esempio può venire dai Democratici americani. I quali grazie a un lavoro intenso, diffuso, articolato, e prolungato, hanno conquistato la Georgia, strappandola al controllo dei Repubblicani. Grazie a una mobilitazione capillare, a un disegno strategico e ad un obiettivo condiviso, Biden e i suoi hanno vinto le elezioni presidenziali nello stato di Atlanta come non succedeva dal 1972 (Presidente Carter), hanno vinto i due seggi senatoriale e nel 2018 per una inezia hanno perso la carica di Governatore. Nel 2012 Renzi aprì la campagna elettorale per le primarie da Verona, nel 2014 il PD risultò primo partito con il 38% in Veneto e il 40% in Lombardia. Il Nord non è una battaglia persa, come talvolta pare sia considerato. Gli elettori sono molto (per i miei standard troppo) mobili e volatili, e cambiano comportamento elettorale con repentina facilità (il 36% nel 2013 e il 26% nel 2018). Purché individuino, elaborino ed indichino una proposta alternativa. E che i dirigenti del centro-sinistra non dicano, come troppe volte accaduto, che quegli elettori sono ontologicamente di “destra” o leghisti e che quindi è possibile vincere solo per un accidente della storia. Il caso virtuoso di Milano, la bella battaglia delle regionali di Ambrosoli del 2013, il tentativo di Gori nel 2018, pur in uno scenario tripolare, le decine di comuni vinti in Veneto, dimostrano che la battaglia è aperta. Togliatti voleva che il PCI avesse una sezione in ogni comune, ovunque ci fosse un campanile; il PD provi almeno a recuperare qualche punto percentuale, perché il Nord determinerà il prossimo assetto parlamentare. Si può fare.